- Blog
- Il linguaggio poetico e le principali f...
Il linguaggio poetico e le principali figure retoriche
In queste lezioni di italiano sul linguaggio poetico analizzeremo tutte le principali figure retoriche.
Indice
Vediamo, prima di tutto, quali sono i principali elementi del linguaggio poetico:
- la lunghezza dei versi, le strofe, la rima, il ritmo, lo schema metrico;
- la scelta delle parole, la loro combinazione, il loro ordine; le aree semantiche;
- le figure retoriche: la similitudine, la metafora; l’allitterazione, l’onomatopea.
Si distinguono versi parisillabi (formati da un numero pari di sillabe) usati in genere per dare un ritmo molto cadenzato ed evidente alla poesia e i versi imparisillabi (formati da un numero dispari di sillabe) che imprimono invece un ritmo più fluido e musicale.
Il verso
Il verso è il segmento fondamentale della struttura metrica. Dal punto di vista tecnico, esso è caratterizzato dal numero delle sillabe e dal ritmo degli accenti. Altri elementi del verso, quali la quantità e il tema, sono secondari nella poesia italiana.
In base al numero delle sillabe, si dice che un verso è:
- endecasillabo (undici sillabe);
- decasillabo (dieci sillabe);
- novenario (nove sillabe);
- ottonario (otto sillabe);
- settenario (sette sillabe);
ecc.
La strofa
La strofa assume nomi differenti a seconda del numero dei versi impiegati: I modelli metrici più usati sono:
- distico (due versi);
- terzina (tre versi);
- quartina (quattro versi);
- sestina (sei versi);
- ottava (otto versi).
La rima
La rima è la ripetizione di suoni identici, di solito nella parte finale del verso a partire dall’ultima sillaba su cui cade l’accento tonico.
La rima assume nomi diversi:
a) baciata: rimano tra loro due versi consecutivi (AA,BB, ecc.);
b) alternata: le rime si avvicendano fra versi dispari e versi pari (ABAB, ecc.);
c) incatenata: in una serie di terzine, il primo verso rima con il terzo, il secondo con il primo della strofa successiva, ecc. (ABA, BCB, CDC, ecc.);
d) incrociata: in una quartina, il primo verso rima con il quarto, gli altri due tra di loro (ABBA).
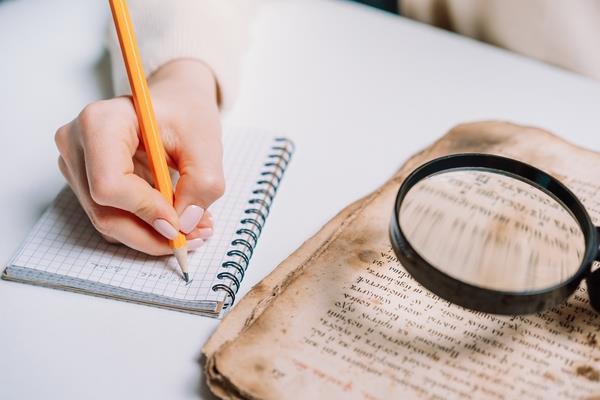
Forme metriche tradizionali
Come i versi sono riuniti in strofe, così le strofe, a loro volta, sono riunite in gruppi. Essi costituiscono forme metriche di componimenti che sono diversi a seconda della lunghezza della strofa e dell’ordine in cui i versi sono disposti. Dalla struttura particolare, essi quasi sempre derivano il loro nome preciso.
La forma metrica è un modo storico di realizzare una particolare tendenza del linguaggio poetico. Perciò alcune forme sono particolarmente usate e tipiche della letteratura italiana. Altre sono di uso più raro. Altre ancora poi, dopo avere avuto molta diffusione e fortuna nei secoli scorsi, oggi non compaiono quasi più.
Tra le forme metriche principali, che ancora sono in uso, è doveroso citare almeno quelle storicamente più illustri:
a) sonetto: forma poetica antichissima, di derivazione provenzale recitata un tempo con accompagnamento di delicati strumenti a corda. Usata da quasi tutti i nostri poeti maggiori, da Dante al Petrarca, al Foscolo, al Carducci, al Montale, ha una struttura elegante e completa, che permette al poeta di condensare in pochi versi il proprio messaggio.
La struttura generalmente prevede:
- versi endecasillabi;
- quattro strofe (le prime due quartine, le altre due terzine);
- rima prevalentemente alternata (ABAB) o incrociata (ABBA) nelle quartine, e a combinazioni varie nelle terzine (CDE CDE oppure CDC DCD, oppure CDC CDC, ecc.).
Es.: Dante Alighieri, “Tanto gentile e tanto onesta pare”; Cecco Angiolieri, “S’i’ fosse fuoco”; Giosuè Carducci, “Funere mersit acerbo”.
b) canzone: forma tipica del componimento lirico. Di derivazione provenzale, è stata trasformata dai poeti toscani del “Dolce stil novo” (sec. XIII) e definita nella sua struttura esemplare dal Petrarca, con versi sempre endecasillabi o settenari e con un numero variabile di strofe, dette stanze, uguali tra loro e chiuse da una strofa più breve detta commiato.
Dopo alcune innovazioni (sec. XVI) che hanno permesso di articolare in modo più libero sia la strofa sia i rapporti tra le strofe, il Leopardi adottò una versione moderna con una metrica libera, in versi praticamente sciolti, dove le rime quando vi sono non hanno collocazione rigida.
Es.: Giacomo Leopardi, “La quiete dopo la tempesta”.
c) terza rima: metro fissato in forma definitiva da Dante Alighieri con la “Divina Commedia” sullo schema seguente: una serie di terzine di endecasillabi, di cui il primo e il terzo rimano tra loro, e il secondo dà la rima alla strofa seguente, fino a che la serie si chiude con un verso isolato che rima con il secondo verso dell’ultima terzina. Largamente adottato specialmente per argomenti di imitazione dantesca e per poesia di intreccio narrativo, torna a nuova fortuna nel Settecento e viene usato anche nell’Ottocento da Foscolo, Leopardi, Carducci, Pascoli, ecc.
Es.: Dante Alighieri, “Inferno”.
d) madrigale: canto popolare a più voci d’argomento amoroso e bucolico e, più tardi, anche morale, quando il metro è usato a livello di poesia d’arte, soprattutto per merito del Petrarca. Lo schema consiste in due o tre strofe di tre endecasillabi rimati variamente fra loro e chiusi da un distico a rima baciata. La sua natura è essenzialmente musicale.
Es.: Petrarca, “Nova angeletta sovra l’ale accorta”.
e) ode: modello di componimento poetico di origine greca che assume varie forme metriche. È consuetudine distinguere due tipi di ode:
- classica, quando cerca di riprodurre il ritmo dei versi antichi della metrica quantitativa dei latini.
Es.: Carducci, “Sogno d’estate”.
- moderna, quando ha versi brevi riuniti in quartine o in sestine.
Es.: Parini, “La salubrità dell’aria”.
Spesso l’ode moderna prende il nome di inno, quando esprime sentimenti particolarmente solenni, religiosi (es. Manzoni, “Inni sacri”), civili (es. Turati, “Inno dei lavoratori”), patriottici (es. Mameli, “Fratelli d’Italia”).
Metro libero
La forma metrica di componimento attualmente più diffusa nella poesia italiana contemporanea si chiama, con definizione molto generica, metro libero. La sua caratteristica è infatti soprattutto in negativo, in quanto non si adegua alle norme tradizionali. I versi non hanno “misura” fissa e prestabilita, seguono ritmi sciolti. La strofa, se esiste, non ha una struttura costante, non è vincolata a un preciso numero di versi. La rima può essere omessa o distribuita nel corso del verso o sostituita da altri artifici fonici, come l’assonanza o l’allitterazione.
Con i suoi versi sciolti, il metro libero appare oggi la struttura poetica più adatta per esprimere, fuori da ogni schema, la ricca tensione ritmica del linguaggio poetico. Non si tratta, in ogni caso, di eliminare le strutture formali: le forme continuamente variabili nei rapporti fonici e sintattici rimandano a un’organizzazione interna, legata soprattutto al senso dinamico e nuovo di ciascun particolare messaggio.
La poesia: analisi strutturale
- Lunghezza dei versi
- Strofe
- Rima
- Forma metrica
- Ritmo
- Schema metrico
- Scelta delle parole, loro combinazione, loro ordine
- Aree semantiche
- Figure retoriche

Le figure retoriche
Traslati
- Allegoria: è una “metafora continuata”, e consiste in una descrizione o in una narrazione che nasconde un significato diverso da quello letterale. Può consistere in una semplice immagine oppure può essere estesa ad un intero brano o ad una intera poesia, se non addirittura ad un poema o ad un romanzo.
Esempi tipici di allegoria sono le parabole del Vangelo e la Divina Commedia (che rappresenta il viaggio di un’anima dalla perdizione alla salvezza).
- Antonomasia: consiste nell’usare un nome comune invece di uno proprio (a) e viceversa (b).
Esempio: (a) Il re del telequiz (Mike Buongiorno); (b) E’ proprio una Venere (una ragazza bellissima).
- Iperbole: consiste nell’esprimere un concetto esagerando in eccesso o in difetto, in modo tale che esso, se inteso letteralmente, sarebbe del tutto inverosimile.
Esempio: Sono cent’anni che non ti vedo! Sei lento come una lumaca.
- Ironia: consiste nell’esprimere un pensiero o un concetto diverso o opposto rispetto a quello che le parole significano.
Esempio: Oh! Che bella pagella! (piena, invece, di brutti voti).
- Metafora: consiste nel trasferimento del significato di una parola ad un’altra, instaurando una relazione di identità o di somiglianza fra i due vocaboli.
Esempio: Oggi mi sento un leone. Quell’uomo ha un cuore di pietra.
- Metonimia: consiste nell’usare un nome invece di una altro, esprimendo i seguenti rapporti:
- la causa per l’effetto (esempio: Vivere del proprio lavoro / Vivere con il guadagno che il lavoro procura);
- l’effetto per la causa (esempio: Il sudore della fronte / Il lavoro che produce il sudore);
- il contenente per il contenuto (esempio: Bere un bicchiere di vino);
- l’astratto per il concreto (esempio: Il disinteresse verso l’ecologia / La gente disinteressata all’ecologia);
- il concreto per l’astratto (esempio: Quell’uomo ha uno stomaco grosso così / Quell’uomo ha una grande capacità di sopportare fatti o persone sgradevoli);
- il mezzo, lo strumento per la persona che lo usa (esempio: E’ la migliore penna dei nostri giorni / E’ il migliore scrittore dei nostri giorni);
- il possessore per la cosa posseduta (esempio: Gli Alpini / le Penne Nere);
- l’autore per la sua opera (esempio: Questo è un Leonardo autentico / Questo è un quadro autentico di Leonardo);
- la materia per l’oggetto da essa costituito (esempio: I marmi del Partendone / Le sculture in marmo del Partendone);
- il luogo invece delle persone che vi si trovano (esempio: Lo stadio si entusiasmò…/ La gente presente allo stadio si entusiasmò…).
- Simbolo: indica persone o cose col nome di altre persone o cose a cui si attribuiscono particolari caratteristiche.
Esempio: La formica (simbolo di industriosità e di lavoro); il lauro (simbolo di gloria poetica).
- Similitudine: è un paragone, un confronto fra due termini fra cui intercorre un rapporto di somiglianza. E’ solitamente introdotto da come, quale, simile a.
Esempio: È bagnato come un pulcino. È forte come un toro.
- Sineddoche: consiste nel chiamare una cosa non con il suo nome ma con un altro, ad essa collegato, che abbia un significato ora più ampio ora più stretto.
Esempio: Il mondo (=gli uomini) è cieco. Beviamoci un bicchierino (=un bicchiere di vino).
Le figure grammaticali
- Alliterazione: è la ripetizione di suoni uguali o simili all’inizio o all’interno di due o più parole successive.
Esempio: Trentatré trentini entrarono tutti e trentatré trottando in Trento.
- Anacoluto: consiste nel susseguirsi, in un medesimo periodo, di due costrutti sintattici diversi, dei quali il primo resta incompiuto.
Esempio: Quelli che muoiono, bisogna pregare Iddio per loro. (Manzoni).
- Anastrofe: consiste nell’inversione dell’ordine naturale delle parole in una frase.
Esempio: Vita natural durante. Eccezion fatta.
- Asindeto: consiste nell’elencazione di vari elementi senza far uso della congiunzione e. Il suo contrario è il polisindeto.
Esempio: Chiare, fresche, dolci acque. (Petrarca).
- Chiasmo: consiste nel disporre due concetti fra loro intimamente legati in modo tale che i termini del secondo siano invertiti, incrociati rispetto al primo (dal nome della lettera greca chi, che aveva la forma di una x).
Esempio: Bisogna mangiare per vivere, non vivere per mangiare.
- Ellissi: consiste nell’omissione di una o più parole (o anche di verbi e frasi) che siano però facilmente intuibili dal contesto.
Esempio: Oggi ho letto un sonetto di Dante, ieri (ho letto) uno di Petrarca.
- Enallage: consiste nell’usare una parte del discorso invece di un’altra.
Esempio: Vi sento forte e chiaro (invece di: fortemente e chiaramente; l’aggettivo è usato al posto dell’avverbio).
L’anno prossimo vado (invece di andrò; il presente è usato al posto del futuro) in vacanza in Grecia.
- Ipallage: consiste nell’invertire la relazione normalmente esistente fra due termini.
Esempio: Il divino del pian silenzio verde (Carducci), dove l’aggettivo verde viene accostato a silenzio anziché a piano.
- Iperbato: consiste nel collocare le parti del discorso in una posizione diversa dal loro ordine naturale, separando elementi che, di norma, sono vicini.
Esempio: La libera dei padri arte fiorì. (Carducci).
- Onomatopea: è una parola che, per mezzo del suo suono, imita rumori, fenomeni naturali, versi di un animale.
Esempio: din-don, tic-tac, bau-bau, gorgoglio, ululare.
- Paronomasia: è l’accostamento, in un periodo o in un verso, di due o più parole di suono simile ma di significato differente.
Esempio: Chi dice donna dice danno; ch’io fui per ritornar più volte vòlto. (Dante).
- Pleonasmo: consiste nell’inserimento di una o più parole, grammaticalmente non necessarie, all’interno di una proposizione.
Esempio: A me non me ne importa niente.
- Polisindeto: consiste nel collegare fra loro gli elementi di una enumerazione usando una medesima congiunzione sempre ripetuta.
Esempio: Ho comprato pane e carne e frutta e dolce.
- Sillessi: consiste nel far concordare due o più elementi della frase in modo non rigorosamente grammaticale, anche se logico.
Esempio: Quanti maleducati c’è (anziché: ci sono) a questo mondo!
- Zeugma: consiste nel far dipendere da una sola parola due o più parole o enunciati, dei quali uno solo è grammaticalmente o logicamente pertinente.
Esempio: Parlare e lagrimar vedrai insieme (Dante), dove vedrai si adatta solo a lagrimar e non anche a parlare; il verbo adatto sarebbe stato sentirai.
Le figure di pensiero
- Antifrasi: consiste nell’usare una parola o un’espressione nel senso contrario a quello proprio, in modo tale da attenuare la crudezza della frase.
Esempio: Quel benedetto ragazzo ne ha combinata un’altra delle sue.
- Antitesi: consiste nel contrapporre ad una parola un’altra di significato opposto o ad un concetto un concetto opposto.
Esempio: Noi tutti desideriamo la pace e non la guerra, la vita e non la morte.
- Apostrofe: consiste nel rivolgere la parola a persone o cose presenti, in forma solenne, appassionata e calorosa.
Esempio: O patria mia, vedo le mura e gli archi. (Leopardi).
Cantami, o Diva, del Pelide Achille l’ira funesta. (Monti).
- Epifonema: è una frase esclamativa di contenuto sentenzioso (solitamente una sentenza morale) che conclude enfaticamente il discorso.
Esempio: Quanta ingratitudine c’è al mondo!
- Eufemismo: consiste nell’usare parole o espressioni gradevoli per significare cose che, in realtà, sono dolorose, sgradevoli, cattive e così via.
Esempio: Passare a miglior vita (anziché: morire). Don Abbondio non era nato con un cuor di leone. (Manzoni).
- Gradazione o climax: si distingue in gradazione ascendente ed in gradazione discendente. La gradazione ascendente consiste nell’aumentare progressivamente l’intensità delle parole o dell’espressione, ina una sorta di “crescendo” verbale.
Esempio: Vegghio, penso, ardo, piango. (Petrarca).
La gradazione discendente o anticlimax presenta, al contrario, una progressiva diminuzione dell’intensità delle parole.
Esempio: Paolo corse, trotterellò, camminò, si fermò.
- Interrogazione: consiste nel rivolgere una domanda a se stessi o ad un’altra persona non per averne una risposta ma per affermare con più forza un proprio pensiero o per esprimere un proprio dubbio.
Esempio: Che farò adesso? Io abbassarmi a chiedergli scusa?
- Ipotiposi: consiste nel rappresentare persone, cose, situazioni o fatti con tale lividezza ed immediatezza da renderli quasi reali e visibili.
Esempio: Come lion di tori entro una mandra
or salta a quello in tergo e sì gli scava
con le zanne la schiena,
or questo fianco addenta or quella coscia.
(Leopardi).
- Litote: consiste nell’affermare una cosa negandone il contrario.
Esempio: Quel ragazzo non è un agnellino (è molto prepotente ed aggressivo).
- Perifrasi: è un giro di parole che si usa per spiegare meglio un concetto o per evitare di esprimerlo direttamente.
Esempio: L’Eroe dei due Mondi (anziché: Garibaldi). La città eterna (anziché: Roma).
- Preterizione: consiste nel dichiarare di non voler dire una cosa che poi, invece, viene detta.
Esempio: E non parliamo neppure del suo ritardo: si è fatto vivo solo due ore dopo!
- Prosopopea: consiste nel far parlare persone assenti o morte, o nel personificare cose inanimate o astratte.
Esempio: Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai, silenziosa luna? (Leopardi).
- Reticenza: consiste nell’interrompere una frase, lasciando il seguito all’immaginazione del lettore.
Esempio: A buon intenditor… (sottinteso: A chi vuol capire, bastano poche parole).
- Ripetizione o anafora: consiste nel ripetere, a breve distanza, una stessa parola o frase, in modo tale da conferire particolare risalto ad un concetto.
Esempio: Per me si va ne la città dolente,
per me si va nell’eterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.
(Dante).


