Graecia capta ferum victorem cepit: similitudini e differenze tra il latino e il greco
Poiché è mia intenzione stuzzicare la curiosità di studenti universitari e liceali (non principianti) piuttosto che elaborare un saggio sistematico, la comparazione linguistica proposta in questo articolo non potrà non essere parziale e semplificata, data l’ampiezza e la complessità della materia. Per la medesima ragione invano il lettore vi cercherà dei riferimenti bibliografici. Chiunque desidera avere dei chiarimenti o approfondire le proprie conoscenze potrà contattarmi accedendo alla pagina del mio profilo: chiedete e vi sarà dato.
Lezione di greco e Latino: similitudini e differenze
Per portare un certo ordine alla trattazione inizierò con le somiglianze e in seguito passerò alle differenze, in entrambi i casi soffermandomi su specifici livelli di analisi, vale a dire: lessico, fonologia, morfologia e sintassi. Per ciascuno di essi ho selezionato un solo argomento, a mio avviso, particolarmente rappresentativo, riservando quasi sempre un certo spazio anche al confronto con l’italiano per agevolare la riflessione linguistica. Proinde incipiamus / Ἀρξώμεθα οὖν.
Somiglianze tra greco e latino
1. Lessico
Sarà bene ricordare da subito che da un punto di vista genealogico il latino e il greco sono riconducibili a un’unica grande famiglia, denominata indoeuropea, la stessa cui appartengono le lingue germaniche (tra le quali inglese, tedesco), le lingue celtiche (tra le quali il gallico di età antica, l’irlandese), le lingue slave (tra le quali il russo) e le lingue indoiraniche (tra le quali l’indiano e il persiano), per menzionarne solo alcune. Perciò non dobbiamo stupirci se nelle due lingue alcuni settori del lessico poco esposti al cambiamento, come i numerali e i vocaboli relativi ai rapporti di parentela, mostrano vistose somiglianze. Ecco una scelta tra gli esempi più perspicui:
|
Greco |
Latino |
Italiano |
|
δύο |
duo |
due |
|
τρεῖς |
tres |
tre |
|
ἕξ (< *σέξ) |
sex |
sei |
|
ἑπτά (< *σεπτ-) |
septem |
sette |
|
ὀκτώ |
octo |
otto |
|
πατήρ |
pater |
padre |
|
μήτηρ (in dorico μάτηρ) |
mater |
madre |
È necessario tuttavia prestare attenzione quando ci si imbatte in corrispondenze lessicali, poiché non sempre si tratta di parole ereditate da un’antica fase comune, come quelle viste poc’anzi. Talora l’origine è differente e vede in gioco l’influenza di una lingua sull’altra, per lo più del greco sul latino. Ebbene sì, la cultura (e con sé la lingua) greca agli occhi dei Romani appariva assai raffinata e quindi superiore: Graecia capta ferum victorem cepit “la Grecia, conquistata, ha conquistato il rozzo vincitore”, come candidamente ammetteva ORAZIO, Epistolae 2, 1, 156 (ed. Klingner). Certo, non senza orgoglio gli scrittori romani come Cicerone si mostrarono quasi sempre restii ad accettare di sana pianta i grecismi ed eventualmente molto più inclini a tradurli (producendo dei calchi), ma nel latino parlato l’ingresso dei prestiti (adattati o meno) deve esser stato molto esteso. Si vedano i seguenti casi:
|
Tipo di forestierismo |
Greco |
Latino |
|
prestito dal greco |
μηχανή (in dorico μαχανά) |
māchĭna da un dialetto dorico |
|
prestito dal greco |
τάλαντον |
talentum |
|
prestito dal greco |
φιλοσοφία |
philosophĭa |
|
calco dal greco |
φιλόλογος |
dicti studiosus cfr. ENNIO, Annales 216 (ed. Vahlen) |
|
calco dal greco
|
προηγμένα (così gli Stoici chiamavano ciò che non è né bene né male, ma è preferibile al male) |
producta cfr. CICERONE, De finibus 3, 52 (ed. Reynolds) |
|
calco dal greco |
οὐσία |
essentia usato già da Cicerone secondo SIDONIO APOLLINARE, Epistula carminis XIV, 4 (ed. Loyen) |
|
calco dal greco |
παρέγκλισις |
clinamen cfr. LUCREZIO, De rerum natura 2, 292 (ed. Deufert) |
Rendiamo però a Cesare quel che è di Cesare! Sebbene in misura minore, anche i Greci non riuscirono a evitare delle conseguenze nella propria lingua: assoggettati militarmente e politicamente, presto si adeguarono alla nuova realtà giuridica e amministrativa, facendo propri soprattutto i termini latini relativi a questi due ambiti. Qualche esempio basterà per farsi un’idea:
|
Tipo di forestierismo |
Greco |
Latino |
|
calco dal latino |
ὕπατος o ἄρχων |
consul |
|
calco dal latino prestito dal latino |
γεφυροποιός ποντίφεξ |
pontifex |
|
calco dal latino prestito dal latino |
Σεβαστός Αὔγουστος |
Augustus |
2. Fonologia
In questa sezione parlerò di un tratto che accomuna le due lingue classiche e al contempo le oppone nettamente all’italiano: la distinzione quantitativa tra vocali lunghe e vocali brevi. Prima di addentrarmi nell’argomento non sarà inutile accennare a due concetti, spesso fraintesi. Mi riferisco alla durata e alla quantità.
Ogni suono (non solo linguistico) ha una sua durata fisica e obiettiva, determinata da vari fattori: nel caso di un discorso orale, per esempio, la velocità di eloquio del parlante oppure la posizione del suono stesso all’interno della catena formata anche dagli altri suoni. La quantità corrisponde invece al tempo relativo che una comunità di parlanti è solita riconoscere e apprezzare in alcune categorie di suoni linguistici, normalmente classificati in due gruppi, brevi e lunghi, a prescindere dalla loro durata effettiva e contingente. Per intenderci, noi italiani oggigiorno siamo soliti percepire consonanti geminate (ossia lunghe) e scempie (ossia brevi), mentre non ha alcuna importanza per noi il tempo delle vocali. Due parole come casa ~ cassa secondo il sistema fonologico dell’italiano differiscono esclusivamente per la diversa quantità della consonante s, nonostante in qualsiasi normale pronuncia dei due esempi, da un punto di vista fisico, la vocale accentata a non sia sempre la stessa: in ca-sa è in sillaba aperta ed è sempre più lunga di quella di cas-sa in sillaba chiusa. Diremo allora che per gli Italiani la differenza tra consonanti geminate e scempie è una differenza di quantità e svolge un ruolo fondamentale nel sistema linguistico: da sola ci consente di distinguere parole del tutto diverse. Invece le differenze temporali che per varie ragioni si possono avere tra le vocali sono solamente differenze di durata e non svolgono alcun ruolo, tant’è che i parlanti non vi prestano attenzione: scommetto che nessuno degli studenti che leggerà quest’articolo se ne era mai accorto prima!
Tornando adesso alle nostre due lingue classiche, credo che l’argomento risulterà più chiaro. Orbene, le orecchie dei Romani e dei Greci avevano senza dubbio una sensibilità diversa da quella che hanno le nostre: percepivano e apprezzavano come brevi e lunghe non solo le consonanti ma anche le vocali. A dimostrarlo è ancora una volta la possibilità di avere vocaboli differenti solamente per la quantità di un singolo fonema (suono linguistico), senza contare che nel greco tutto ciò è in parte ancor più esplicito per via dell’utilizzo di lettere diverse per alcuni timbri vocalici. Per il timbro e si distingue quantità breve (ε) e lunga (η); per il timbro o quantità breve (ο) e lunga (ω). (In verità l’opposizione quantitativa nei dialetti greci del gruppo ionico-attico era più articolata: ricordiamo che ει e ου talora non sono dittonghi, ma solo digrammi, ossia due lettere per indicare un unico suono, in tal caso rispettivamente una e e una o lunghe e chiuse, contrapposte a η e ω lunghe e aperte). Vediamo degli esempi per completezza:
- ānus “anello” ~ ănus “donna anziana” (cfr. anche ănnus “anno”).
- lēvis “liscio” ~ lĕvis “lieve”.
- mālus “melo” ~ mălus “cattivo”.
- λέγω “dico” ~ λήγω “smetto”.
- ὅς (pronome relativo) “il quale” ~ ὥς “così”.
- φορά “trasporto” ~ φωρά “furto”.
Insomma, la percezione della quantità varia da lingua a lingua e si badi bene, la distinzione quantitativa nelle vocali non è una peculiarità di quelle antiche: la si ritrova per esempio in arabo. Chi vuole studiare questa lingua, da subito impari a non confondere ğamāl “bellezza” con ğamal “cammello”, altrimenti rischierebbe di incappare in situazioni molto imbarazzanti!
3. Morfologia
Se c’è una caratteristica nel latino e nel greco che molesta di solito gli studenti italiani (o addirittura li terrorizza), questa è il caso grammaticale. Soltanto a sentirne parlare sopraggiunge l’incubo delle flessioni senza fine e delle numerose desinenze da imparare a memoria. Per tale ragione, mi auguro che questo paragrafo possa dissipare timori e false opinioni molto frequenti tra i banchi di scuola riguardo a questo argomento.
Anzitutto iniziamo col dire che il greco e il latino, secondo la tipologia morfologica, sono classificabili nel tipo detto fusivo, proprio come l’italiano. Nelle lingue di questo gruppo le parole variabili (o declinabili) presentano un elemento morfologico finale, detto morfema grammaticale o più comunemente desinenza, nel quale si fondono (da qui il nome fusivo) più valori di categorie grammaticali diverse. Per esempio, nel nome italiano porta abbiamo una desinenza -a in cui sono racchiusi i valori di numero singolare e genere femminile. A differenza dell’italiano però i nomi, i pronomi, gli aggettivi e i participi delle due lingue classiche presentano desinenze in cui oltre al genere e al numero trova posto anche il caso. Nelle parole lup-um “lupo” e ἥλι-ον “sole” le desinenze esprimono i valori non solo del genere maschile e numero singolare, ma anche del caso accusativo.
Ma che cos’è esattamente il caso, questo fantomatico concetto apparentemente così estraneo alla nostra lingua italiana? Si tratta semplicemente di una fondamentale categoria grammaticale, come il numero o il genere, mediante la quale si indicano le funzioni logiche e sintattiche di nomi, pronomi, aggettivi e participi all’interno di una frase. A ben vedere, dunque, la differenza tra l’italiano da una parte e il greco e il latino dall’altra risiede solo nel fatto che l’italiano non esprime i valori dei casi morfologicamente, cioè mediante desinenze, ma solo sintatticamente con il concorso di altre parole. Due esempi chiariranno il tutto. Nella frase
il filosofo vede il medico
è solo l’ordine dei costituenti che ci permette di comprendere che il medico è l’oggetto diretto, ossia è in funzione di caso accusativo. Ancora, se diciamo
il filosofo parla al medico
la preposizione articolata al e il verbo parla non lasciano dubbi che si tratta di oggetto indiretto, ossia al medico esprime la funzione di caso dativo. Osserviamo adesso le medesime frasi tradotte in latino e greco. In
philosophus videt medicum / ὁ φιλόσοφος ὁρᾷ τὸν ἰατρόν
la funzione di accusativo è espressa esclusivamente dalla desinenza -um/-ον, non dall’ordine dei costituenti della frase; se lo alterassimo infatti non cambierebbe alcunché nel significato generale. Lo stesso vale anche per il secondo esempio:
philosophus dicit medico / ὁ φιλόσοφος λέγει τῷ ἰατρῷ
dove la funzione di caso dativo è racchiusa soltanto nella desinenza -o/-ῳ, senza l’ausilio di preposizioni.
Se vogliamo essere ancor più precisi, tuttavia, il greco e il latino non esprimono i valori casuali solo e sempre a livello morfologico con delle desinenze, come negli esempi visti sopra. Il numero dei casi morfologici (cioè delle desinenze) non è infatti sufficiente e in combinazione con essi talora si ricorre a preposizioni specifiche per indicare le altre molteplici funzioni logiche e sintattiche. Consideriamo il moto a luogo (ossia la funzione allativa/illativa). In latino e in greco si impiega di norma una preposizione come in o ad / εἰς o πρός seguite dal caso morfologico accusativo, perché nelle due lingue non esiste una desinenza (un caso morfologico) riservata a questa funzione di moto:
philosophus it ad medicum / ὁ φιλόσοφος ἔρχεται πρὸς τὸν ἰατρόν.
La realtà delle singole lingue è infatti quasi sempre molto più complessa delle generalizzazioni cui siamo abituati.
In conclusione, spero che la distinzione tra caso morfologico (espresso mediante desinenze) e caso marcato sintatticamente porterà a vedere questa categoria grammaticale con occhi diversi da prima, se non altro consentendo di estendere il concetto anche alla nostra lingua. Certo, resta la questione del numero dei casi morfologici: sette in latino (nominativo, genitivo, dativo, accusativo, vocativo, ablativo) e sei in greco (nominativo, genitivo, dativo, accusativo, vocativo). Se siete ancora convinti che sia impossibile che lingue con così tanti casi morfologici possano funzionare ed essere apprese, vi assicuro che vi sbagliate. Volgete lo sguardo altrove e capirete il perché. Sapete quanti casi morfologici si riconoscono nel finlandese? ... Ben 16 e vi risparmio di elencarli: altro che latino e greco!
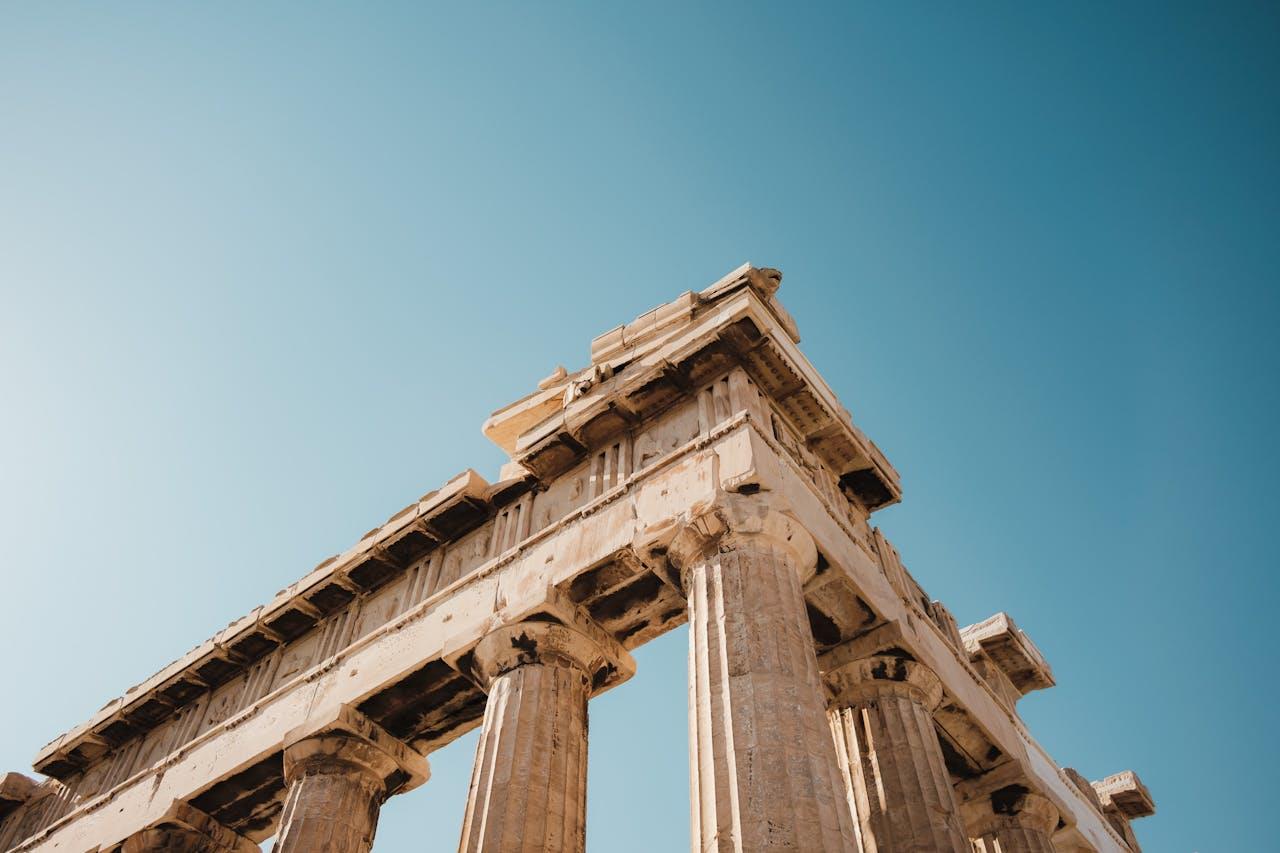
4. Sintassi
Per la sintassi ho scelto di mettere a confronto due costrutti assai ricorrenti nelle due lingue, con evidenti somiglianze già a partire dalla loro denominazione. Mi riferisco al genitivo assoluto del greco e all’ablativo assoluto del latino. Come è noto, sono chiamati in tal modo perché esprimono una proposizione subordinata con il verbo participio e il soggetto al genitivo in greco e all’ablativo in latino, senza legami con i costituenti della reggente, sciolta rispetto a questa, absoluta appunto:
magistro legente discipuli rident
ἀναγιγνώσκοντος τοῦ διδασκάλου οἱ μαθηταὶ γελῶσιν.
Tuttavia, se è vero che la sovrapposizione tra le due costruzioni nelle due lingue è spesso così palese e direi scontata, è altrettanto vero che possono incontrarsi delle divergenze. Anzitutto per quanto concerne il carattere assoluto della proposizione participiale. In greco infatti, a dispetto della consueta denominazione, il costrutto non di rado presenta dei legami con la reggente e perciò cessa di essere assoluto. In particolare il soggetto al genitivo può riferirsi a qualcuno o qualcosa espresso nella proposizione principale, talora anche al soggetto di questa, laddove in latino sono categoricamente evitate simili relazioni. Vediamo un esempio che in italiano suona mentre Odìsseo entrava in casa, la dea gli apparve:
παρίοντος εἰς τὴν οἰκίαν Ὀδυσσέως ἡ θεὰ αὐτῷ ἐπεφάνη.
Il soggetto in genitivo della subordinata (Ὀδυσσέως) è richiamato dal pronome αὐτῷ, un uso impossibile nell’ablativo assoluto latino, tant’è che la frase si potrebbe tradurre solo in altro modo (di seguito con il participio congiunto in dativo):
Ulixi domum ineunti dea apparuit.
Un altro tratto che differenzia a volte le due lingue risiede nella presenza del participio: in greco è sempre espresso, pure quando si tratta del verbo essere, mentre in latino si possono incontrare frasi puramente nominali, anche perché non esiste il participio di esse. Per esempio:
- EURIPIDE, Βάκχαι 773-774 (ed. Diggle) Οἴνου δὲ μηκέτ’ ὄντος οὐκ ἔστιν Κύπρις / οὐδ’ ἄλλο τερπνὸν οὐδὲν ἀνθρώποις ἔτι “Se non c’è più vino, non c’è più Afrodite né altro piacere per gli uomini”.
- P. Mucio L. Calpurnio consulibus mortuus est “Morì al tempo dei consoli Publio Muzio e Lucio Calpurnio”.
- Me teste hoc promisit “Ha promesso questo davanti a me testimone”.
Un ultimo aspetto è l’omissione del soggetto della costruzione subordinata: in greco non è così rara come lo è invece in latino, dove è limitata a due casi. Primo, quando si usa un participio perfetto da intendersi come neutro (cognito “conosciuta la cosa”, nuntiato “annunziato il fatto”, etc.). Secondo, quando ad essere omesso è un pronome dimostrativo riferito a un relativo:
- SENOFONTE, Ἀγησίλαος 2, 10 (ed. Marchant) Συνιόντων δὲ τέως μὲν σιγὴ πολλὴ ἦν “Mentre si avvicinavano, nel frattempo vi era grande silenzio”.
- CICERONE, De divinatione 1, 3 (ed. Giomini) Romulus non solum auspicato Urbem condidisse, sed ipse etiam optumus augur fuisse traditur “Si tramanda che Romolo non solo abbia fondato la città dopo aver preso gli auspici (intendi “inaugurato il fatto con auspici”), ma anche che sia stato un ottimo augure”.
- CURZIO RUFO, Historiae Alexandri Magni 9, 1, 20 (ed. Müller, Schönfeld) Oppidani missis (intendi iis), qui regem deprecarentur, nihilo minus bellum parabant “Gli assediati, pur essendo stati inviati quelli che implorassero il re, ciononostante preparavano la guerra”.
Considerando quanto scritto sopra nel paragrafo sul lessico, lo studente forse crederà che le somiglianze tra genitivo assoluto e ablativo assoluto siano dovute all’influenza del greco sul latino, come se i Romani anche in questo fossero degli imitatori. No, con buona pace dei Greci! Si tratta di costruzioni caratteristiche di non poche lingue indoeuropee, a cambiare è solo il caso morfologico utilizzato: in antico indiano abbiamo per esempio il locativo assoluto.
Differenze tra greco e latino
1. Lessico
Tutte le parole (meglio ancora, i lessemi) di qualsiasi lingua possono essere classificate in categorie lessicali, quelle che noi siamo soliti chiamare parti del discorso sulla scia del latino partes orationis, a sua volta traduzione dal greco τὰ μέρη τοῦ λόγου. Proprio qui, nelle categorie che tradizionalmente i grammatici antichi riconoscevano per le due lingue classiche, spicca una vistosa differenza: si tratta dell’articolo determinativo, individuato dai Greci, ma assente in latino, tant’è vero che una delle stranezze che gli studenti cominciano da subito a notare in questa lingua è senz’altro questa, abituati come sono agli articoli il lo la i gli le dell’italiano.
Ovviamente, di tale mancanza i Romani ne erano ben consapevoli, come apprendiamo da QUINTILIANO, Institutio oratoria 1, 4, 19 (ed. Radermacher) Noster sermo articulos non desiderat “La nostra lingua non ha bisogno degli articoli”. È anche interessante notare che nella scuola antica molti grammatici latini finirono per trattare come articolo il pronome dimostrativo hic: il complesso di inferiorità verso i Greci era grande a tal punto da spingerli a colmare la mancanza, dando artificiosamente a questo pronome un valore che di fatto non aveva! È per tale ragione che il più famoso grammatico della tradizione romana, Elio Donato, il pronome hic lo denominava articulare praepositivum vel demonstrativum (DONATO, Ars minor 3, p. 589 (ed. Holtz)).
Soffermandoci sul greco però dobbiamo aggiungere delle precisazioni, dato che in realtà l’articolo determinativo ὁ ἡ τό non è sempre usato come tale. Si tratta infatti di un originario pronome dimostrativo (“questo”, “quello”), attestato con questo valore non solo in tante altre lingue indoeuropee ma anche nel greco stesso. Nei poemi omerici per esempio le occorrenze sono assai numerose:
- OMERO, Ἰλιάς 1, 8-10 (ed. West) Τίς τάρ σφωε θεῶν ἔριδι ξυνέηκε μάχεσθαι; / Λητοῦς καὶ Διὸς υἱός· ὃ γὰρ βασιλῆϊ χολωθείς / νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ὦρσε κακήν “Chi degli dei li spinse in discordia a combattere? Il figlio di Latona e Zeus. Quello infatti, adirato con il re, fece sorgere una funesta pestilenza tra l’esercito”.
Non bisogna tuttavia risalire fino a Omero e ai poeti arcaici per averne esempi. Degli usi residuali sono attestati ancora nel più tardo dialetto attico e sono anche molto frequenti. Si pensi solo alla correlazione tra ὁ / ἡ / τό μέν [...] ὁ / ἡ / τό δέ “questo / questa” [...] “quello / quella”:
- SENOFONTE, Κύρου ἀνάβασις 2, 2, 5 (ed. Hude) Καὶ τὸ λοιπὸν ὁ μὲν ἦρχεν, οἱ δὲ ἐπείθοντο “Anche dopo di allora l’uno comandava, gli altri ubbidivano”.
Ci tengo a sottolineare che la mancanza dell’articolo determinativo tutto sommato non è una stranezza latina: moltissime lingue, come la maggior parte di quelle slave (per esempio il russo), pur non possedendolo sono parlate e funzionano perfettamente. L’italiano, e così le altre lingue romanze nate dal latino, se lo possiedono è soltanto per via di un’innovazione. Ancora una volta è dai pronomi dimostrativi che bisogna partire. Nel caso dell’italiano le forme lo e la provengono dall’accusativo del latino ille illa: (IL)LŬ(M) > lo e (IL)LĂ(M) > la.
2. Fonologia
Ho voluto dedicare questo paragrafo all’accento, un tratto prosodico fondamentale in qualsiasi lingua. Preciso però da subito che mi soffermerò principalmente sulle differenze concernenti la sua posizione all’interno della parola, toccando appena il problema della sua natura. La ragione di tale scelta è dovuta alla vexata quaestio che ancora oggi perdura a proposito dell’accento latino. Non è infatti del tutto chiaro se fosse di tipo intensivo oppure tonale (detto anche musicale): nel primo caso, come nell’italiano, ciò che i parlanti colgono e apprezzano è la variazione di intensità (o volume) tra il nucleo delle sillabe toniche (accentate) e quello delle atone (non accentate), maggiore nelle prime rispetto alle seconde. Nei sistemi accentuativi tonali, come nel greco antico o nello svedese, invece, ciò che conta è essenzialmente la variazione di frequenza (o altezza o tono) tra il nucleo delle sillabe toniche e quello delle atone, più alta nelle prime rispetto alle seconde.
Riguardo alla natura dell’accento greco molto si deduce già da come lo descrivevano i grammatici antichi: il termine προσῳδία “accento” (da πρός e ᾠδή “canto”) non lascia molti dubbi sul suo carattere musicale. Infatti le espressioni ἡ ὀξεῖα / ἡ βαρεῖα / ἡ περισπωμένη συλλαβή “sillaba acuta / grave / circonflessa” indicavano rispettivamente la sillaba con innalzamento tonale (o di frequenza), la sillaba con nessuna variazione tonale e la sillaba con innalzamento e abbassamento tonale in successione (il simbolo del circonflesso cui siamo abituati ~ è l’esito dell’evoluzione grafica di ˄, ossia acuto / + grave \). Da notare che l’uso dei segni paragrafematici per gli accenti cui siamo abituati oggi risale a epoca bizantina ed è molto diverso da quello antico a noi noto tramite i papiri. In particolare l’accento grave, che secondo la consuetudine medioevale e moderna si pone al posto dell'acuto sull’ultima sillaba di parola seguita da un’altra parola non enclitica (Διὸς πατήρ), in realtà anticamente era posto sulle sillabe atone a marcare assenza di elevazione tonale (Δὶος πὰτηρ).
Per il latino, al contrario, tutto si presenta più complesso per via della totale dipendenza dei grammatici romani dalla terminologia e dai modelli descrittivi impiegati dai colleghi greci: la parola stessa accentus (da ad e cantus) altro non è che un calco da προσῳδία!
Fatta questa premessa, concentriamoci adesso sulla posizione. Iniziamo dicendo che nelle due lingue classiche non vi sono solo divergenze. Hanno infatti in comune la cosiddetta legge del trisillabismo, secondo la quale l’accento non risale mai oltre la terzultima sillaba. Parole con la quartultima sillaba accentata, come le bisdrucciole dell’italiano (per esempio scìvolano), in latino e in greco sono impossibili.
Quanto alle differenze, sono due i fenomeni prosodici che distinguono chiaramente il latino dal greco, fenomeni di solito descritti nelle grammatiche latine mediante due leggi: la legge della baritonesi e la legge della penultima. Per baritonesi si intende la ritrazione dell’accento dall’ultima sillaba: è per tale ragione che in latino parole con più di due sillabe non sono mai ossitone (ossia con ultima sillaba accentata), eccezion fatta per poche forme secondarie, frutto di mutamenti fonetici. Ne elenco alcuni esempi:
- avverbi con originario suffisso in -cĕ passato a -c per apocope: illīc, istūc, posthāc.
- imperativi dei composti di dico e duco, in origine terminanti in -cĕ: addīc, addūc.
- nomi originariamente in -ātis o -ītis, interessati da sincope di ĭ in sillaba finale: nostrās < nostrāt(ĭ)s, Arpinās < Arpināt(ĭ)s, Samnīs < Samnīt(ĭ)s.
Prima di procedere ricordiamo però che la baritonesi non è del tutto estranea alla lingua greca. Certo lo è nel dialetto attico, troppo spesso considerato per errore da noi “il greco”. Diverso è tuttavia il sistema accentuativo del lesbico letterario, rappresentato principalmente dalla lirica monodica di Saffo e Alceo: qui la ritrazione dell’accento – sempre nei limiti della legge del trisillabismo e quindi mai oltre la terzultima sillaba – era costante.
- ALCEO, 308b, 2 (ed. Lobel, Page) θῦμος (in attico θυμός).
- SAFFO, 1, 2 (ed. Lobel, Page) Δίος (in attico Διός).
Veniamo ora alla fondamentale legge della penultima in latino, chiamata così per l’importanza che in questa lingua ricopre la quantità della penultima sillaba: se essa è lunga sarà anche accentata; altrimenti, se è breve, ad essere accentata sarà la terzultima. Diremo allora scribĭmus con l’accento sulla sillaba scri, ma monēmus con l’accento sulla sillaba ne.
In greco viceversa nulla del genere. È piuttosto la quantità dell’ultima sillaba a vincolare, in parte, la posizione dell’accento: se essa è lunga, l’accento non potrà cadere sulla terzultima sillaba, bensì soltanto su una delle ultime due; se invece è breve, allora l’accento potrà collocarsi in una delle ultime tre sillabe (in una delle ultime due se si tratta però del circonflesso, mai sulla terzultima). Per tale ragione nel corso della flessione di alcune parole si assiste allo spostamento dell’accento:
- ὁ ἄνθρωπος ma τοῦ ἀνθρώπου.
- οἱ γίγαντες ma τῶν γιγάντων.
- λύομαι ma λυοίμην.
3. Morfologia
Quando i ragazzi italiani cominciano a studiare greco nel liceo classico hanno l’opportunità (o forse la sciagura, penseranno alcuni di loro) di incontrare per la prima volta una nuova categoria grammaticale fino a quel momento a loro sconosciuta: l’aspetto verbale. Ciò è inevitabile perché questa categoria ricopre un ruolo centrale nel sistema del verbo della lingua greca, a differenza del latino e anche dell’italiano, dove l’altra categoria, quella del tempo, ha ormai preso il sopravvento. Per noi italiani infatti un qualsiasi processo verbale si colloca anzitutto in una dimensione temporale, scandita in un prima (passato), un mentre (presente) e un dopo (futuro) in rapporto al momento dell’enunciazione. Ci potrà sembrare strano, ma questa attitudine in verità è il risultato di una progredita capacità di astrazione, una conquista alla quale siamo giunti solo con l’avanzare del tempo (scusate il gioco di parole!). L’uomo primitivo era portato invece a osservare un’azione o un evento in modo più diretto, secondo una prospettiva interna al tempo stesso: un’azione o un evento possono essere considerati anzitutto come compiuti (aspetto perfettivo) o incompiuti (aspetto imperfettivo), a prescindere dalla loro posizione nell’asse temporale. Prendiamo esempi dall’italiano. Se diciamo
Marco leggeva il tuo messaggio quand’ecco Emilio bussò alla porta
e
Marco aveva (appena) letto il tuo messaggio quand’ecco Emilio bussò alla porta,
l’unica differenza che intercorre tra le due proposizioni principali con il verbo leggere non risiede nel tempo (passato nell’una e nell’altra) ma nell’aspetto: l’imperfetto leggeva esprime un processo verbale incompiuto nel passato, mentre il trapassato prossimo aveva letto un processo verbale compiuto egualmente nel passato.
Da quanto detto si comprende che l’aspetto verbale in realtà trova spazio in tutte le lingue, compreso l’italiano. Se non siamo abituati a notarlo è perché siamo indotti per prima cosa a collocare qualsiasi processo verbale nell’asse temporale, proprio come facevano i Romani. Le stesse frasi di sopra possono tradursi in latino così, con le medesime distinzioni aspettuali:
Marcus epistulam tuam legebat cum subito Aemilius ostium pulsavit
(Vixdum) Marcus epistulam tuam legerat cum subito Aemilius ostium pulsavit
Per il latino infatti si può individuare una generale opposizione aspettuale tra sistema dell’infectum (incompiuto) e sistema del perfectum (compiuto) sempre inquadrata nella categoria del tempo e a essa subordinata:
|
|
Infectum |
Perfectum |
|
Passato |
legebam, legerem (imperfetto) |
legeram, legissem (piuccheperfetto) |
|
Presente |
lego, legam (presente) |
legi, legerim (perfetto) |
|
Futuro |
legam (futuro semplice) |
legero (futuro perfetto) |
Al contrario, per i Greci i verbi esprimevano anzitutto un valore di aspetto e solo al modo indicativo si affianca a esso un preciso valore temporale, ma non nei restanti modi, ossia congiuntivo, ottativo, imperativo, infinito e participio (l’unica eccezione è il tempo futuro in quanto formazione tardiva necessariamente legata alla categoria temporale). È per tale ragione che da subito nel liceo ci viene spesso ripetuto che l’aoristo ha valore di passato (ossia di tempo) solo all’indicativo. Ed è sempre per tale ragione che parlare per esempio di congiuntivo o infinito presente, a ben vedere, è fuorviante in quanto non hanno di per sé valore di tempo presente!
Dunque, la differenza del greco rispetto al latino sta nella maggiore arcaicità del suo sistema verbale. E infatti se per il latino, come abbiamo detto, si individua una principale coppia di valori aspettuali (compiuto ~ incompiuto), nel greco si conserva meglio una triplice distinzione, secondo la maggior parte dei linguisti, ereditata dal protoindoeuropeo e riscontrabile nell’indiano antico:
|
Durativo (o imperfettivo) |
Aoristo (o puntuale) |
Perfetto (o retrospettivo) |
|
φευγ- tema del presente azione incompiuta vista nel suo svolgersi: “fuggire”, “essere in fuga”. |
φυγ- tema dell’aoristo azione pura e semplice senza riferimenti al suo svolgersi: “fuggire”, “andarsene”, “svignarsela”. |
πεφευγ- tema del perfetto azione compiuta e/o il suo risultato: “essere fuggito”, “essere libero”. |
Per maggiore chiarezza possiamo rappresentare visivamente le differenze nel modo seguente: in particolare, le parentesi quadre delimitano la dimensione temporale; la linea continua indica l’azione compiuta, mentre la tratteggiata l’azione incompiuta; il punto l’azione in sé e per sé; infine la lettera x la posizione del soggetto rispetto al processo verbale. Quanto all’ultima illustrazione, si noterà come il soggetto può assumere due posizioni: all’interno del processo verbale, precisamente in corrispondenza del suo compimento, oppure all’esterno, in rapporto retrospettivo a indicarne il risultato.
imperfettivo (durativo) [————x‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒]
perfettivo aoristico (puntuale) [ x̣ ]
perfettivo compiuto/risultativo (retrospettivo) [—————————x]x
Vediamo qualche esempio:
- EURIPIDE, Φοίνισσαι 1684 (ed. Diggle) Ἀλλ’ εἰ γαμοίμην, σὺ δὲ μόνος φεύγοις, πάτερ; “Ma che accadrebbe se io avessi un marito e tu invece stessi da solo in esilio, o padre?”. L’ottativo "presente" esprime la condizione di Èdipo esule.
- ESCHILO, Ἱκέτιδες 777-778 (ed. West) Ποῖ φύγωμεν Ἀπίας χθονὸς κελαινὸν εἴ τι κεῦθός ἐστί που; “In quale luogo della terra apia dovremmo andarcene, se mai vi sia un qualche oscuro nascondiglio?”. Il congiuntivo aoristo indica un’azione puntuale, senza riferimenti alla sua durata: le Danàidi sono già fuggite ad Argo e si domandano dove troverebbero un ulteriore luogo in cui fuggire.
- SOFOCLE, Φιλοκτήτης 1044 (ed. Lloyd-Jones, Wilson) δοκοῖμ’ ἂν τῆς νόσου πεφευγέναι “Mi parrebbe di essere libero dalla malattia”. L’infinito perfetto indica un’azione giunta a compimento (“essere fuggito”) oppure il suo risultato (“essere libero”).
Dunque, possiamo dire che nella lingua greca accanto all’aspetto imperfettivo (proprio del tema del presente) abbiamo due ben distinte sottospecie dell’aspetto perfettivo, vale a dire il perfettivo compiuto/risultativo (proprio del tema del perfetto) e il perfettivo aoristico (proprio del tema dell’aoristo). Che questo sistema tripartito sia originario nella famiglia linguistica indoeuropea sembra confermarlo indirettamente il latino, se ci soffermiamo per un poco sul suo perfetto indicativo. Quando cominciamo a studiare il verbo latino, spesso restiamo colpiti dai diversi valori che assume questa forma:
- perfetto storico traducibile in italiano con il passato remoto: lēgi “lessi”.
- perfetto logico traducibile in italiano con il passato prossimo: lēgi “ho letto”.
- perfetto risultativo traducibile in italiano con il presente: memĭni “ho richiamato alla mente” e quindi “ricordo”.
Alla luce di quanto già detto spiegare il perché adesso è facile: nel perfetto latino sono confluiti sia l’antico aoristo del protoindoeuropeo sia il perfetto vero e proprio. È per tale ragione che alcuni verbi hanno un perfetto sigmatico, con suffisso in -s- tipico dell’aoristo (scripsi da scribo; dixi da dico), mentre altri un raddoppiamento caratteristico del perfetto indoeuropeo (dĕdi da do; pĕpĕri da pario).
4. Sintassi
Se sopra a proposito delle somiglianze tra genitivo assoluto e ablativo assoluto abbiamo avuto a che fare con la macrosintassi (sintassi del periodo), qui scenderemo invece al livello della microsintassi (sintassi della proposizione). In particolare ho intenzione di soffermarmi su un uso peculiare del greco, noto nella tradizione grammaticale come schema attico (Ἀττικὸν σχῆμα), perché molto frequente nella prosa attica, ma senza dubbio attestato anche altrove, in primis Omero ed Erodoto. Si tratta di un’anomala concordanza tra un soggetto al neutro plurale e un verbo al singolare, come per esempio:
- PLATONE, Κρατύλος 402A (ed. Hermann) Λέγει που Ἡράκλειτος ὅτι πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει “Da qualche parte Eraclìto dice che tutto è in movimento e nulla sta fermo”.
- ERODOTO, Ἱστορίαι 1, 193, 3 (ed. Rosén) Τὰ δὲ φύλλα αὐτόθι τῶν τε πυρῶν καὶ τῶν κριθέων τὸ πλάτος γίνεται τεσσέρων εὐπετέως δακτύλων “In questa stessa regione le foglie del frumento e dell’orzo diventano facilmente di quattro dita in larghezza”.
L’anomalia però ha una precisa spiegazione: la desinenza plurale dei neutri in -ᾰ, attestata anche in altre lingue indoeuropee (tra le quali il latino), in origine non esprimeva propriamente il valore di numero plurale, bensì di collettivo. In un esempio come τὰ ζῷα τρέχει “gli animali corrono” il soggetto era inteso nel senso non tanto di “gli animali”, ma di “l’insieme degli animali”.
Non mancano però eccezioni a questo fenomeno, anche tra gli autori attici. Soprattutto quando il soggetto neutro indica esseri umani oppure chi scrive vuole evidenziare la pluralità insita nel soggetto stesso, la concordanza torna a essere normale (ed è quest’ultima che troviamo ormai generalizzata nel greco ellenistico):
- OMERO, Ἰλιάς 11, 724 (ed. West) τὰ δ’ ἐπέρρεον ἔθνεα πεζῶν “Le schiere dei fanti accorrevano”.
- SENOFONTE, Κύρου ἀνάβασις 1, 7, 17 (ed. Hude) ἀλλ’ ὑποχωρούντων φανερὰ ἦσαν καὶ ἵππων καὶ ἀνθρώπων ἴχνη πολλά “Ma erano visibili le molte orme e di cavalli e di uomini che si ritiravano”.
Quanto al latino, lo schema attico è del tutto estraneo a questa lingua: i nomi neutri sono sempre legati a un verbo al plurale. Perciò si faccia attenzione a non lasciarsi influenzare dal greco quando si scrive in latino!
- VIRGILIO, Aeneis 6, 309-310 (ed. Conte) Quam multa in silvis autumni frigore primo / lapsa cadunt folia “Quante le foglie staccatesi al primo freddo autunnale cadono nei boschi”.
I rarissimi esempi, come il seguente tratto da Petronio, sono solo in apparenza un’eccezione. Nel caso specifico credo che non sono lontani dal vero coloro che vedono in triclinia non un normalissimo neutro plurale, ma un femminile singolare. I passaggi dei nomi dalla II declinazione neutra alla I femminile (chiamati metaplasmi) non erano infrequenti nella lingua parlata e non lo sono sulla bocca dei liberti del romanzo petroniano:
- PETRONIO, Satyrica 71, 10 (ed. Ernout) Faciatur, si tibi videtur, et triclinia “Si faccia anche il triclinio, se per te va bene”.

